
La CASA sul NILO, di Denise Pardo (Beat – settembre 2024)

È la storia, in buona parte autobiografica, di una famiglia ebrea con radici mitteleuropee, russe e italiane, arrivata in Egitto ai primi del ‘900, che si intreccia alle vicende storiche e politiche di quel paese fino all’ inizio degli anni ’60. Anni cioè in cui fu costretta a lasciare un mondo che le si era rivoltato contro.
Non nascondo che mi ha richiamato molto alla mente aspetti della società levantina tanto presenti nelle opere di Fausta Cialente. Ma qui il punto di vista è diverso e soprattutto diversi i tempi storici.
Ritroviamo l’Egitto crocevia di popoli, religioni, lingue e culture quale fu fino a tutti gli anni cinquanta. Tale era il cosmopolitismo che all’ interno della famiglia o di un gruppo di amici al bar si intrecciavano nella stessa conversazione arabo, francese, yiddish, russo… né si disdegnavano festività e pratiche religiose diverse dalle proprie e non mancava il rispetto per i dipendenti o i domestici indigeni.
Ecco, però in primo piano, con i loro modelli e stili di vita, qui troviamo una classe sociale elevata, ricca se non ricchissima, dedita al lavoro ( oltre che allo svago) impegnata nelle produzioni e nei commerci, che comunque si sentiva parte integrante del paese, sebbene non ignorasse le sregolatezze e gli sprechi del sovrano, da una parte, né l’ estrema miseria di tanta popolazione dall’ altra.
Ma nel giro di pochi anni, attraverso rivoluzioni, guerre, nazionalizzazioni, l’ avvento al potere di Nasser, la repubblica, cambierà tutto: la convivenza pacifica viene ridotta, prima lentamente poi in un crescendo di intolleranza. Gli stranieri (che tali non si sentivano) si scoprono presi di mira, dal governo e dalla popolazione; crescono a dismisura l’antisionismo e l’ antisemitismo; gli inglesi sono oggetto d’odio. In poche parole anche per la famiglia dei protagonisti le illusioni crollano e sono costretti ad abbandonare il paese e quella vita dorata.
È un libro di atmosfere, descritte con vivacità e precisione, per il periodo spensierato del benessere, quello di un mondo patinato, colto ed elegante, e poi con malinconia e stupore per il periodo dell’ abbandono, della perdita di sé, della propria l’identità.
“La diversità mi metteva all’angolo, avrei voluto essere come loro [ le nuove compagne di scuola] perché avevo conosciuto l’agiatezza di sentirsi uguale agli altri nell’Egitto cosmopolita. Sembrava un paradosso ma in un’Italia piena di prevenzioni ero io a essere diventata esotica”.
Toccante la nostalgia del paesaggio, del clima, del cibo, dei sapori e degli odori non meno degli amici e di altre persone con le quali si è condivisa parte della vita.
Questi sono i sentimenti che vengono messi in evidenza ed ancora una volta ci si potrebbe chiedere «chi è lo straniero?»
Si potrebbe pensare , leggendo, ad un modo per guardare alla fine del colonialismo , considerando le sorti di coloro che erano dalla parte degli oppressori. In realtà se è giusto il cammino di un popolo verso l’autonomia e l’ Indipendenza, politica ed economica, vedere in ogni straniero un nemico a cui chiudere le porte può essere negativo oltre che pericoloso.
Ma torno a dire che questo è un romanzo di sentimenti e (citando la recensione editoriale) ” la storia di un tempo perduto e di un tempo ritrovato a fatica. Ci mostra mondi dove tutto era scambio e curiosità, rispetto e attenzione [ …] un tempo diverso e più giusto”
Recensione di Maria Guidi
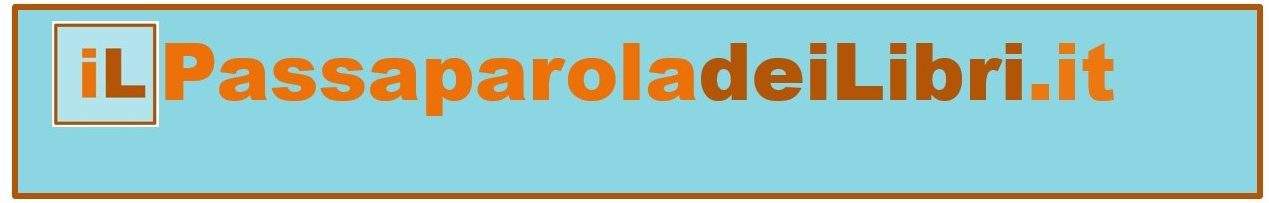


Commenta per primo