
LA CONDIZIONE DELLA MEMORIA, di Giulia Corsalini (Guanda – gennaio 2024)

Quando, qualche anno fa, lessi “L’insostenibile leggerezza dell’essere” di Milan Kundera, rimasi colpita da due parole che lo scrittore utilizzò in un passaggio del romanzo, ricordando il passato di un personaggio, ossia “la memoria poetica”, cioè “quella memoria che registra tutto ciò che ci affascina o ci commuove, tutto ciò che rende intensa la nostra vita”.
È a partire da questa frase che ho riflettuto su questo romanzo, per me nutrimento importante, poiché, con la memoria e la sua disgregazione, ne ho toccato i profondi abissi a contatto con la “malattia del non ricordo” che ha colpito un mio familiare.
Di memoria e della sua condizione in particolare nel rapporto complesso, e a volte difficile, tra una madre e la propria figlia vengono qui raccontati in un presente che ha del sapore dell’autunno, della senescenza ma che affonda le radici in un passato emotivo-affettivo denso di significativo e che animerà il futuro da costruire.
In una tarda primavera, Anna, figlia cinquantenne dell’anziana Maria, decide di trascorre qualche settimana nella zona della Ciociaria insieme alla madre stessa.
Un borgo quasi deserto, dove le imposte sono chiuse, dimenticate da persone che sono fuggite nelle città vicine con maggiore prospettive. Dove l’erba si inerpica sulla dorsale rocciosa, ma soprattutto un luogo quasi ancestrale, perché è lì che è nata, ormai tanti anni fa, la stessa Maria.
Un luogo che sprigiona un po’ alla volta la memoria del tempo antico, in quella casa a ridosso della collina, con il suo orto un tempo lussureggiante e il giardino ombroso. Una casa come focolare domestico, in cui aleggiano i fantasmi delle zie, del nonno e delle sue mogli.
Fra quelle fotografiche virate in seppia, sopra mobili antichi, tra quelle lenzuola orlate di pizzi preziosi, Maria ed Anna si ritrovano sole, accompagnate dal rumore dei ricordi, che la madre non desidera rivelare, e che la figlia vorrebbe ascoltare.
Come un gioco di rimandi però il passato torna a galla, attraverso immagini che parlano di profumi che si sprigionano, di anziani che raccontano. Maria è reticente, la sua memoria inizia ad essere avvolta dalla nebbia, sembra in qualche modo passare il testimone alla figlia.
Anna è però pronta ad accoglierlo?
Sembra di sì e non ne ha timore.
E così le settimane si fanno mesi e in quel lasso di tempo Maria la si vede bambina con la sorellina, scorrazzare tra le vie del borgo; Maria che ha conosciuto, suo malgrado, l’abbandono della propria madre, accudita da tre zie zitelle.
Ma Maria, di quella privazione ne ha fatto tesoro e per la figlia si è sempre fatta presenza, donna forte, di valore, nel suo esserci, nel suo stare di madre.
Nel borgo antico sembra ricostruito un focolare domestico, fatto di poche parole ma di molto significati, complessi ma veri, viscerali.
Si racconta di antiche dimore, che sembrano parlarsi anch’esse l’una con l’altra in un ancestrale passato mitico, corposo, iconico.
Madre e figlia impareranno, forse, a respirare all’unisono così come non avevano mai fatto prima, tra i non detti e i silenzi. E il passato e la sua memoria però è sempre lì una lancinante nostalgia, così come lo sono le nostre radici, il nostro passato originario rappresentato da quel folto gruppo di immigrati che risiede nella villa antica di fronte alla casa di Maria. Anche loro vivono di memoria poetica, cercano di trattenere il bello dei loro ricordi dei luoghi natii, (tema peraltro ricorrente nei romanzo di Giulia Corsalini, come “La lettrice di Cecov”). Immigrati aiutati nel loro vivere quotidiano da il nipote di un antico discendente del borgo, Luca, che diverrà ponte tra il passato e il presente di Maria, Anna e del borgo stesso.
Passato e presente che danzano e che la memoria considera, nella sua condizione di memoria, appunto.
Madre e figlia che ad un certo punto della trama invertiranno i propri ruoli: la figlia diventerà madre della propria madre. Anna e il suo desiderio di trattenere, Maria ormai conscia che bisogna lasciare andare.
La penna dell’autrice è sensibile, delicata e utilizza la scrittura come balsamo per lenire le sofferenze. Una penna evocativa che rende perfettamente il legame, il vincolo filiale materno, indissolubile. Non c’è però rassegnazione o tristezza, seppur la malinconia è un velo sottile che pervade il racconto, ma il tempo dedicato loro permette di raccontarsi in modo diverso; è acqua di vita, permette di leggersi, comprendersi nel profondo, tra le stanze in penombra e in quello specchio che si può trovare nel salone che ferma attimi e si fanno eterni, soffusi, di una tenebra azzurra tra il sole e la notte.
Durante la lettura ho immaginato un gomitolo, che lascia andare il suo filo, intrecciato poi con altri fili. Fili come le vite dei protagonisti del romanzo che insieme formano la matassa della vita universale.
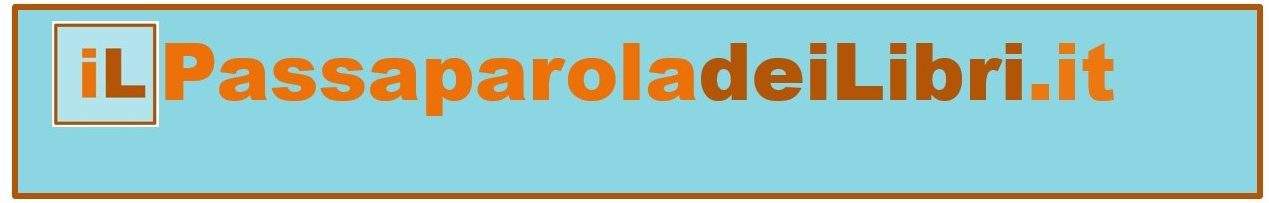


Commenta per primo